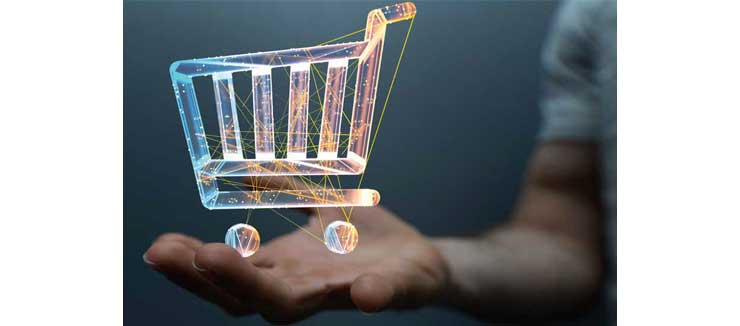““Inflazione significa essere povero con tanti soldi in tasca.”
(Ugo Tognazzi)
La Germania durante la Repubblica di Weimar, all’indomani del conflitto mondiale del 1915-1918, sperimentò, a causa della guerra perduta, una svalutazione pazzesca del marco tedesco. Nel periodo tra il 1919 e il 1923 l’inflazione raggiunse il 662,6% annuo. Durante questo periodo il marco arrivò a valere un bilionesimo [1/1.000.000.000.000] di quanto valesse nel 1914. Nel 1923 per spedire una lettera occorrevano decine di miliardi di marchi, nei ristoranti il conto raddoppiava nel corso del pasto, una libbra di burro (500 grammi) costava 3400 marchi in febbraio e 280 miliardi in novembre, tanto era galoppante l’inflazione. Oltre 300 cartiere non facevano che produrre giorno e notte la carta moneta da stampare. E le cifre sulle banconote avevano numeri di milioni di bilioni (un bilione equivale a mille milioni). Sono tanti i problemi che assillano il nostro tempo in questo momento e tra questi, dal punto di vista economico, uno è piuttosto subdolo, anche se palese e palpabile. Stiamo parlando dell’inflazione che, se non galoppa come ai tempi della Repubblica di Weimar, di certo è ormai presente nel mondo occidentale e la pandemia da Covid, nonché il conflitto russo-ucraino, hanno dato un grosso aiuto a questa infezione dell’economia.
Il vincitore del premio Nobel per l’economia Milton Friedman ha affermato che “l’inflazione è sempre e ovunque un fenomeno monetario”, cioè determinato dalla quantità di moneta presente in un preciso momento in un sistema economico. Forse è per questo motivo che diversi esperti stanno incolpando le banche centrali per l’attuale aumento prolungato del costo della vita. Quello che sembrano dimenticare è che la teoria economica fornisce alcune qualificazioni all’affermazione generale di Friedman. In particolare, vi è una distinzione tra inflazione causata da un eccesso di domanda persistente e inflazione causata da uno shock negativo dell’offerta, mentre l’attuale contesto può rappresentare un terzo tipo: l’inflazione che è guidata da un periodo prolungato di variazioni dei prezzi relativi nell’economia. Il tipo più semplice di inflazione da affrontare per le banche centrali è quello causato dal surriscaldamento, quando la domanda supera l’offerta. Un mercato del lavoro persistentemente teso può aumentare sostanzialmente il potere contrattuale dei lavoratori, portando a un’accelerazione della domanda salariale. A causa della carenza di manodopera, i datori di lavoro accetteranno queste richieste, in parte perché sanno che l’elevata domanda di beni e servizi che producono consentirà loro di aumentare i prezzi alla produzione in risposta a costi salariali più elevati. Spesso si dimentica che, affinché una tale spirale salari-prezzi inizi ad autoalimentarsi, l’economia deve trovarsi in uno stato di persistente surriscaldamento. La politica monetaria può facilmente prevenire questa situazione poiché non c’è limite all’aumento del tasso ufficiale. Ciò significa che la banca centrale può anche aumentare senza limiti gli oneri finanziari del settore pubblico e privato, con il risultato che per i crediti vanno pagati interessi più elevati, il che smorza l’attività d’investimento delle imprese e la voglia di spendere dei consumatori. Questo equivale a versare un secchio di acqua fredda sul conflitto distributivo acceso poiché i lavoratori e i datori di lavoro perdono la capacità di aumentare rispettivamente i salari e i prezzi. Scenario completamente differente si verifica quando l’economia subisce uno shock di offerta negativo, per esempio un Paese importatore netto di energia è colpito da un suo aumento dei prezzi. Inequivocabilmente il reddito reale per il Paese nel suo insieme risulterà ridotto; in altre parole, l’inflazione aumenterà e la crescita rallenterà. La domanda in tale scenario è se la banca centrale debba stringere a causa dell’aumento dell’inflazione o allentare la politica a causa della minore crescita. Tuttavia, se le aspettative di aumento dei prezzi sono percepite dagli attori economici come temporanee, la politica monetaria può rimanere in sospeso o addirittura essere allentata per attutire i rischi al ribasso per la congiuntura. L’aumento dei prezzi dell’energia farà aumentare l’inflazione, ma una volta che questi smetteranno di aumentare o inizieranno a scendere, quest’ultima tornerà al suo livello obiettivo di propria iniziativa.
Quello che è successo negli ultimi due anni è qualcosa di differente. Le banche centrali dei mercati sviluppati hanno dovuto far fronte a una serie di cambiamenti strutturali nei modelli di consumo e produzione che hanno innescato squilibri tra domanda e offerta. Un esempio noto è l’aumento della richiesta di beni a livelli ben al di sopra del trend pre-Covid, che si è scontrato con strozzature nell’offerta. La risoluzione di questi squilibri richiede una variazione dei prezzi relativi. Ad esempio, i prezzi devono salire nei settori in cui vi è un eccesso di domanda rispetto ai prezzi nei settori caratterizzati da un eccesso di offerta. Queste variazioni si tradurranno in un aumento dell’inflazione generale perché i salari e diversi costi alla produzione sono vischiosi al ribasso: infatti, se questi ultimi nei settori con un eccesso di offerta non possono diminuire (contratti pluriennali, lotte sindacali, ecc…), i salari e i prezzi nei settori in cui vi è un eccesso di domanda tenderanno ad aumentare di più. Fino allo scorso anno prevaleva un’aspettativa che l’aumento del costo della vita correlato alla riapertura post-pandemia si sarebbe attenuato. Tuttavia, sembra sempre più che una normalizzazione potrebbe essere difficile da raggiungere per qualche tempo. Il conflitto in Ucraina ha innescato nuove strozzature nell’approvvigionamento e ha provocato il divampare di quelle vecchie. A questo si aggiunge che il processo di deglobalizzazione in atto sotto forma di catene di approvvigionamento più brevi e regionali porta con sé un aumento dei costi di produzione. Inoltre, la transizione verso energie più sostenibili implicherà un inevitabile aumento dei prezzi al consumo: è improbabile che sia un affare tranquillo il disinvestimento dalle fonti più inquinanti a favore dell’energia verde. Il risultato è che, a causa della viscosità al ribasso dei salari e dei prezzi, probabilmente aumenterà anche il tasso medio di inflazione che, se dovesse persistere abbastanza a lungo, è destinato a portare anche a un aumento delle sue aspettative, con ripercussioni molto più gravi sul sistema economico. In base a quanto scritto risulta evidente che le banche centrali dei Paesi occidentali dovranno affrontare un nuovo contesto in cui l’inflazione non è causata da un eccesso di domanda persistente, ma piuttosto da una serie prolungata di shock che innescano squilibri tra domanda e offerta in varie aree dell’economia e quindi dovranno scegliere tra accettare un’inflazione media leggermente più alta o una crescita economica più debole.
In linea di massima una leggera inflazione è auspicata dal mondo politico ed economico. La banca centrale statunitense, ad esempio, punta a un costo della vita del due per cento annuo, perché ciò assicurerebbe un’espansione congiunturale. In prospettiva di un rialzo dei prezzi, le aziende investono. E poiché gli affari delle imprese vanno a gonfie vele, esse possono anche pagare stipendi più elevati. Di conseguenza, i consumatori acquistano di più. Entrambi i fattori rappresentano premesse importanti per un’economia sana, senza trascurare che una leggera inflazione protegge dalla deflazione, che potrebbe inibire la ripresa e sfociare persino in una crisi. Tuttavia, anche un’inflazione troppo esuberante può rallentare la crescita economica, poiché ridurrebbe oltremisura il potere d’acquisto, scoraggiando di nuovo gli investimenti. Per questi motivi l’obiettivo è mantenere un’inflazione stabile. Ovviamente, tutto ciò ha ripercussioni sui mercati finanziari. Se si investe in azioni si possono dormire sonni tranquilli, in quanto storicamente il mercato azionario possiede una copertura abbastanza buona contro l’inflazione. Nel lungo periodo, i ricavi e gli utili di una società dovrebbero aumentare allo stesso ritmo dell’inflazione, per cui i prezzi delle azioni dovrebbero salire insieme ai prezzi generali dei beni di consumo e di produzione. L’eccezione a questo scenario è la stagflazione: la combinazione di un’economia ferma con un incremento dei costi è negativa per i titoli azionari. Non tutte le aziende accolgono un aumento dell’inflazione allo stesso modo: per esempio, una società con molta liquidità registrerà un calo di valore con l’aumento dell’inflazione. Il problema più generale sul mercato azionario con l’inflazione è che i rendimenti di una società tendono a essere sopravvalutati. In tempi di alta inflazione, una società può sembrare prospera, quando in realtà è l’inflazione il motivo dietro la crescita apparente. L’inflazione può essere particolarmente problematica per gli investimenti a reddito fisso. Con il passare del tempo, il potere d’acquisto di questi pagamenti diminuisce in risposta all’inflazione. In altre parole, l’aumento di quest’ultima danneggia chi investe in obbligazioni in due modi: erode il loro potere d’acquisto, nel caso in cui ricevano pagamenti fissi mentre i prezzi di beni e servizi aumentano costantemente, e riduce il prezzo stesso dei bond a condizione che gli aumenti dei tassi di interesse previsti vengano scontati dal mercato. Il tasso di interesse è una variabile chiave nella determinazione del valore delle cedole (cioè i pagamenti periodici delle obbligazioni). Ecco perché le sue variazioni influiscono sul prezzo dei bond. Infine, i risparmiatori che hanno potuto mantenere liquidità sui conti correnti senza preoccuparsi troppo di un’inflazione fino a pochi mesi fa bassissima, vedono ora seriamente minacciato il valore reale del loro risparmio. Se questa restasse agli attuali livelli, tra soli dieci anni il risparmio non investito potrebbe valere la metà di quanto vale oggi. La combinazione tra un costo della vita elevato e tassi di interesse comunque molto contenuti rende particolarmente difficile la protezione del risparmio: continuare a restare non investiti equivale quindi a un vero e proprio “suicidio finanziario”. Moltissimi italiani tuttavia non investono e lasciano i loro soldi sul conto per paure più o meno immotivate (mancanza di educazione finanziaria) o per scarsa fiducia nel sistema creditizio.
La commissione europea ha recentemente rivisto le stime sull’inflazione al rialzo e sulla crescita al ribasso. La questione, tuttavia, è quanto siano attendibili queste previsioni, alla luce delle difficoltà che hanno avuto tutti i previsori nell’anticipare la vigorosa ripresa economica mondiale e la forte crescita dei prezzi che si registra oggi e si ha l’impressione che stime di natura essenzialmente estrapolative non aiutino molto a prevedere il futuro in un momento di forti cambiamenti. Se pochi, sulla base delle esperienze pandemiche passate e dei periodi post-bellici, erano riusciti ad anticipare una intensa crescita economica, nessuno aveva messo in conto un’esplosione inflazionistica della portata di quella attuale. Ci eravamo abituati a un’inflazione bassa e stabile, al di sotto degli obiettivi delle banche centrali. Il contesto odierno sembra diverso: inflazione in aumento, secondo le stime probabilmente per un periodo prolungato. Insomma, l’inflazione non rientrerà nel tubetto del dentifricio tanto facilmente.