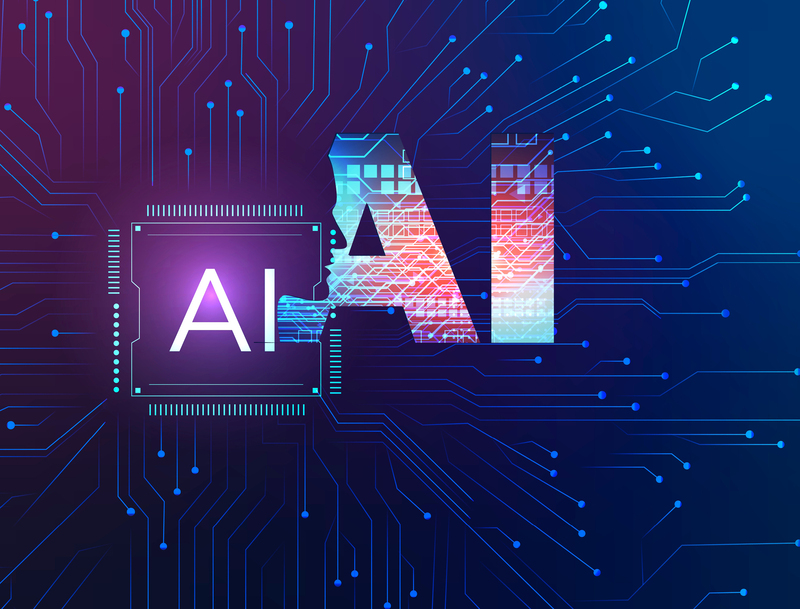C’è chi la incensa. E chi la teme. L’Intelligenza Artificiale ormai è una realtà. Ma è ancora tutto da verificare l’impatto che avrà sulla società e nell’economia
Oggi più che mai l’Intelligenza Artificiale, o più semplicemente – anglicizzando – l’AI, suscita passioni divisive, da Bar Sport. Ci sono le frange dei tecnofili più estremi: è cosa buona e giusta, risolverà un mucchio di problemi e inaugurerà un’epoca di paradiso in terra. Grazie a lei vivremo felici e contenti, liberati per sempre dalle fatiche più alienanti. Controindicazioni? Zero. La paura che la macchina divenga inarrestabile e metta l’uomo in schiavitù, tipo quella evocata da film come Terminator o 2001: Odissea nello spazio? Lasciamola alla fantasia distopica di certi registi di Hollywood. Elon Musk è forse il più famoso araldo di questo orientamento.
Poi ci sono i tecnoscettici. Per loro l’AI non è per nulla una rosa senza spine. E si affrettano a mettere tutta una serie di paletti grossi così. Occhio, dicono. L’espressione in sé è nient’altro che un ossimoro, fortunato fin che si vuole dal punto di vista del marketing ma che sotto sotto nasconde un colossale equivoco. I computer infatti calcolano, lo faranno anche benissimo, ma l’uomo, solo lui, pensa, crea in modo autonomo, in più ponendosi domande originali di questo genere: da dove veniamo e dove andiamo, perché l’essere e non piuttosto il nulla, cose così.
Solo lui, sempre l’uomo, è dotato di autocoscienza. E di sentimenti. I confronti e le analogie sono impossibili. Da una parte abbiamo spiriti e anime, dall’altra Golem capaci di eseguire gli ordini alla lettera ma senza comprenderne il significato. Dunque non illudiamoci troppo. E poi (per non tirare in ballo i teorici più estremi delle insidie della tecno-scienza alla Heidegger o alla Anders) già Ludwig Wittgenstein ammoniva che il progresso appare sempre più grande di quello che è.
Ma insomma, la verità da che parte sta? Un po’ di luce su un tema così dibattuto e attuale ha tentato di farla il convegno-tavola rotonda svoltosi a fine settembre nella sala congressi della sede centrale del Banco di Desio. Un parterre di esperti che la materia, per differenti motivi, la conosce bene. A cominciare dal relatore principale, Stefano Quintarelli, guru di Internet e di tecnologie digitali (ideatore dello SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale), parlamentare dal 2013 al 2018, votato dal Corriere-Economia come uno dei trenta imprenditori più innovativi in Italia. Quintarelli ha tenuto una corposa lectio dal titolo I sottomarini non nuotano: cosa è davvero l’intelligenza artificiale e come funziona. Insieme a lui, sul palco, l’amministratore delegato di Banco Desio Alessandro Decio, Alessandro Profumo, ex a.d. di Unicredit e di Leonardo e oggi presidente dell’advisory board di Rialto Ventures, Emanuele Marcianò, a.d. di Dune Tech Companies e Riccardo Monti, presidente di Triboo spa.
Per Quintarelli, diciamo così, la virtù sta nel mezzo. L’AI è una cosa straordinariamente utile, come è stato utile Internet e come lo sono state tutte le novità via via introdotte dall’uomo a partire, 11.000 anni fa, dalla nascita dell’agricoltura.
Questo non esime dall’indagarne criticamente le caratteristiche con occhio storicamente orientato: «Iniziamo a dire – spiega – che l’avventura che ha portato all’Intelligenza Artificiale parte da molto lontano, da quando l’uomo ha iniziato a pensare alle proprie azioni e a cercare di creare strumenti in grado di automatizzarle. La logica è la stessa di qualsiasi utensile, essere di qualche utilità all’uomo per renderlo più potente. Certo, con L’AI il livello di sofisticazione aumenta, soprattutto dal punto di vista quantitativo. Possiamo indicare nel 1950 la data spartiacque. Per la prima volta Alan Turing, lo scienziato che decodificò il codice segreto tedesco “Enigma”, si chiese se una macchina potesse pensare e rispose affermativamente col test che porta il suo nome (imitation game). Il test si basa su un dialogo tra una persona e una controparte che l’umano non può vedere, una macchina: se l’umano non riesce a stabilire se il partner del dialogo è un suo simile o un computer (quel che ora viene denominato sistema chatbot), a giudizio di Turing si può affermare che il computer esibisce un comportamento intelligente. Anche se quest’ultimo termine personalmente lo metterei tra virgolette. L’Intelligenza Artificiale ha poco da spartire con l’intelligenza per come ognuno di noi la intende. È un modo di fare software basato su algoritmi ed elaborazioni statistiche, che manca totalmente, e non potrebbe essere diversamente, di alcuni aspetti caratteristici dell’intelligenza umana, come la capacità congiunta di astrarre e dedurre, di coinvolgere aspetti emotivi, di includere creatività, di essere autoconsapevole. Non basta introdurre variazioni e casuali, inserire variabili random nei procedimenti algoritmici o statistici. È necessario inoltre distinguere l’Intelligenza Artificiale ristretta da quella Generale. Mentre la prima è già una realtà che pervade le nostre giornate e i nostri spazi, l’Intelligenza Artificiale Generale, che indica un sistema che riesce ad adattarsi in modo autonomo e a risolvere qualsiasi compito gli venga assegnato, indipendentemente dal contesto d’inserimento, è ancora un’utopia non raggiungibile, sia per limiti tecnologici che per mancanza di comprensione del funzionamento di molti dei meccanismi dei sistemi cui dovrebbe adattarsi. Comunque nessuna macchina è o sarà mai in grado di compiere tutte le funzioni e tutti i compiti che un essere umano, seppur più lentamente, può portare a termine. Qualcuno ha detto – conclude Quintarelli – che quando un’intelligenza artificiale sarà in grado di piangere i propri cari, allora si potrà dire realmente intelligente».
Posto il confine tra noi e lei, restano le incognite. Alcune sono state evidenziate recentemente persino da Bill Gates, tutto meno che un bieco luddista. Sarebbero tre: rischio di disruption a livello occupazionale (un rapporto di Goldman Sachs del 2023 stima che l’AI potrebbe influenzare 300 milioni di posti di lavoro a tempo pieno); uso improprio (crimini informatici e bioterrorismo); cosiddetto “scenario di perdita di controllo”, cioè l’AI che surclassa l’intelligenza umana.
Le tematiche esaminate dagli altri relatori, in particolare Marcianò e Monti, hanno riguardato più nello specifico quelle legate alla sicurezza, alla privacy, alla riservatezza e alle opportunità economiche delle Pmi, che, dicono, hanno contro ogni apparenza ottime chance di poter competere con i big player. Un’AI legata all’ottimizzazione delle previsioni, all’analisi, al supporto delle decisioni, la cosiddetta “AI noiosa”, non potrà non avere un impatto positivo in termini di efficienza sulla bottom line delle aziende, anche se questo non dovesse riflettersi per forza a livello dei ricavi. Il discorso riguarderà soprattutto quelle aziende medio-piccole – l’aspetto sottolineato in particolare da Marcianò – che sapranno cogliere le opportunità offerte da questa innovazione: flessibilità e rapidità decisionale potranno consentir loro di vincere rispetto a gruppi più capitalizzati ma condizionati dalle pastoie della burocrazia interna. Un po’ come nel calcio, dove non sempre a primeggiare sono i club che hanno speso miliardi.
Per Alessandro Decio e Alessandro Profumo, guardando all’AI applicata alla finanza, non ci si può nascondere che molto resta ancora da fare per comprenderne il possibile utilizzo in questo settore. Di sicuro – questo l’aspetto sottolineato con decisione da entrambi – l’uomo deve essere sempre presente nel processo decisionale. Si usa dire che la tecnica è buona o cattiva a seconda di cosa ne facciamo ed è vero. I dilemmi etici, morali e giuridici non potranno mai essere di competenza di un computer.
Intanto il mercato fa capire che l’onda sta montando. L’AI nel 2024 vale 184 miliardi di dollari ma con un tasso previsto di crescita del 28% all’anno nel 2030 il business dovrebbe essere di 826 miliardi e coinvolgerà 729 milioni di utenti rispetto ai 314 attuali. Solo il tempo a venire ci dirà se l’Intelligenza Artificiale è una nuova lampada di Aladino, strumento di liberazione di tutti e di ciascuno o, al contrario, un “genio maligno”, un dispositivo di assoggettamento e sorveglianza sociale. O magari un misto delle due cose. Vada come vada, di sicuro ne vedremo delle belle.